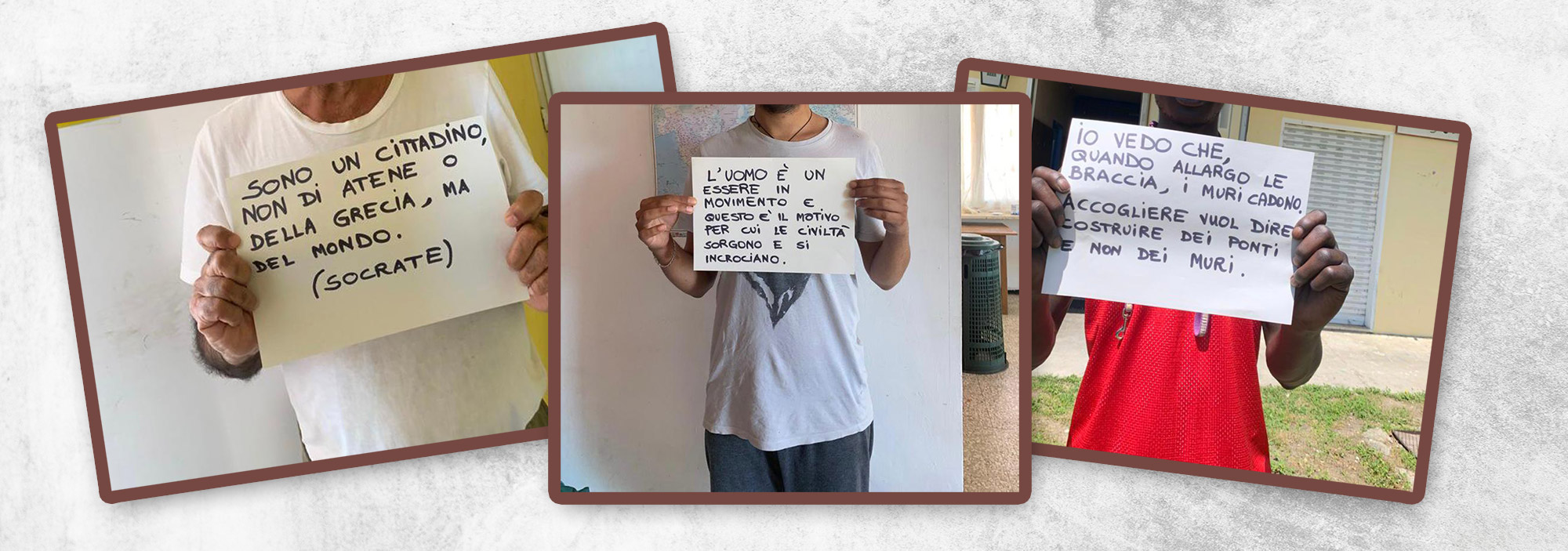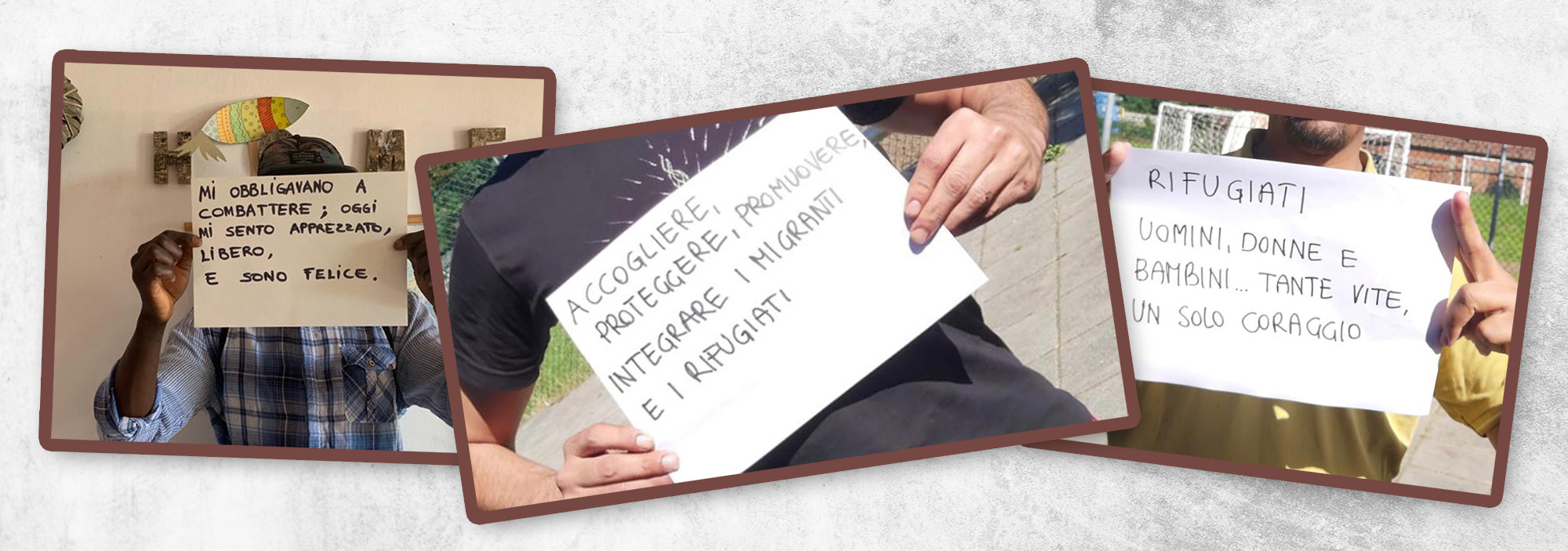L’Italia è una terra che, più di ogni altra, ha conosciuto la migrazione. Per secoli l’ha vissuta sulla propria pelle come Emigrazione. Dalla metà del diciannovesimo secolo fino a oggi, milioni di cittadini Italiani hanno dovuto lasciare la propria terra per trovare una vita decente altrove. Infatti, oggi, anche se il termine emigranti è caduto in disuso, oltre il circa 5 milioni di cittadini nati in Italia e residenti all’estero, ci sono tra i 60 e 80 milioni di Oriundi, i discendenti dei migranti, nelle americhe e nel Nord Europa.
Dopo la II° Guerra Mondiale il paese entra in una fase di industrializzazione veloce che lo porta alla ricostruzione post bellica, poi all’uscita dalla povertà fino a diventare una delle maggiori potenze industriali del pianeta. Questo frena progressivamente i flussi di emigrazione verso l’estero. E poi, verso la fine degli anni 70′ comincia a costituirsi un flusso in entrata di Immigrazione.
Come succede spesso, i primi migranti erano per alcune nazionalità solo uomini che lavoravano nell’agricoltura, nell’edilizia, nel commercio. Per altre nazionalità, c’erano solo donne che lavoravano nella collaborazione domestica (donne di servizio, assistenti di cura per anziani, bambini e persone malate). Si parlava di immigrazione invisibile. Braccia senza pretese nè diritti.
Alla fine degli anni 80 il numero era cresciuto tanto, in modo particolare con arrivi significativi dal Marocco e dall’Albania. Nel 1990 fu adottata la prima legge quadro, detta legge Martelli, che regolarizzava la presenza dei cittadini stranieri sul territorio italiano, dando loro un riconoscimento ufficiale.
L’arrivo in Italia di popolazioni di origine magrebina negli anni 80′ e albanese negli anni 90′, ha generato situazioni nuove e che richiedevano una nuova legislazione, prima negli ambiti lavorativo, scolastico e sanitario, poi in seguito, in quelli della gestione dell’ordine pubblico, la giustizia, l’amministrazione pubblica, gli sportelli di informazione, le banche e in vari altri ambiti. Nel frattempo i numeri e le aree di provenienza delle nuove popolazioni aumentavano.
Urgeva l’ingresso in campo di una nuova figura professionale, quella del Mediatore Culturale, in grado di tradurre la lingua, spiegare la cultura, aiutare a risolvere problemi, proporre soluzioni, mediare nei conflitti, progettare e valorizzare le risorse per una convivenza pacifica tra i cittadini di origine straniera da una parte e la popolazione e le istituzioni italiani dall’altra.
Passando gli anni, con l’arrivo dei flussi di profughi dall’Africa e da altre zone del mondo in guerra, la figura del Mediatore Culturale entra a giocare un ruolo centrale nei Centri di Accoglienza Temporanea per adulti e per minori.
I primi corsi per “mediatori”
E’ intorno agli anni 1990-1995 che iniziano i primi grandi corsi di formazione per i Mediatori Culturali. Generalmente finanziati dalle Regioni o dal Ministero del Lavoro, alcuni altri dal Fondo Sociale Europeo.
La disciplina richiede, oltre alla conoscenza della lingua di origine e dell’italiano, anche una buona conoscenza sia della cultura di origine degli immigrati che quella del paese di approdo. Il profilo ideale del Mediatore Culturale si definisce quindi da sé: un immigrato che ha una buona conoscenza del paese e della cultura d’origine e che ha vissuto abbastanza in Italia da conoscerne bene la lingua, le usanze, la cultura, il sistema politico, sociale, amministrativo e culturale. La formazione serve a dare una migliore conoscenza del territorio e delle istituzioni e strumenti per mediare.